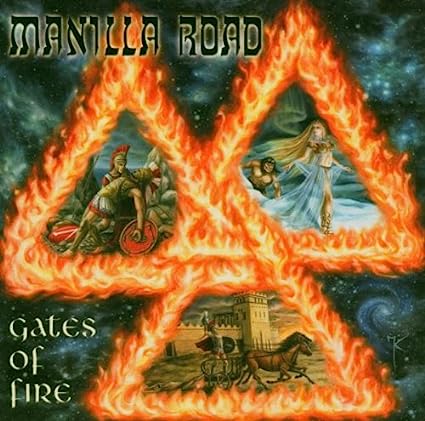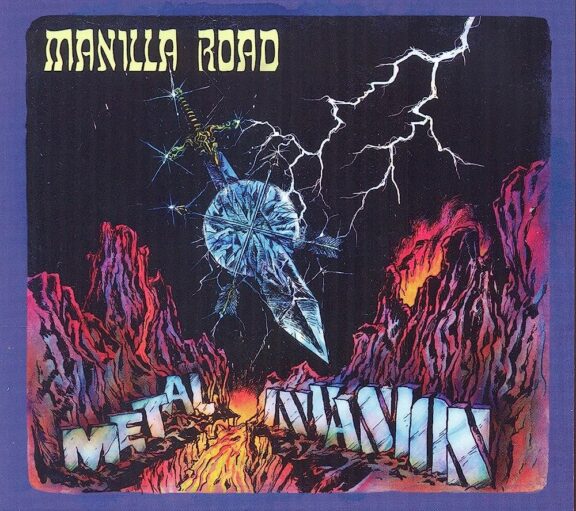Recensione: To Kill a King

Si ferma al ragguardevole traguardo di 18 capitoli l’epopea musicale dei Manilla Road: diciotto album da studio che, dal 1980 al 2017, hanno appassionato gli amanti dell’epic metal più oscuro, ipnotico e cavernoso. “To Kill a King”, introdotto da un’amletica copertina del nostrano Paolo Girardi, arriva a due anni dal precedente “The Blessed Curse” (ve ne avevo parlato qui) e costituisce, per i motivi che noi tutti purtroppo conosciamo, il testamento musicale del gruppo di Wichita. Le coordinate del lavoro sono, ovviamente, sempre le stesse a cui Mark Shelton e i suoi pards ci hanno abituato: un mix tra epic metal sulfureo e maligno e derive di rock settantiano che donano al tutto quel profumo antico, ipnotico ed evocativo che è da sempre il marchio di fabbrica di Mr. Shelton. Come spesso accade, quando si parla dei Manilla Road, l’attenzione del gruppo è concentrata sulla creazione di atmosfere evocative più che sullo sviluppo di pezzi facilmente assimilabili, e anche quest’ultimo lavoro non fa eccezione. “To Kill a King” non è né un disco semplice né accattivante, ma necessita di ripetuti ascolti per essere compreso e metabolizzato a dovere.
Dieci tracce per un’ora e spicci di musica lenta, densa e cadenzata, che solo in rare occasioni si apre a passaggi più selvaggi e punteggiata, come sempre, dall’onnipresente solismo di Shelton. Si parte con la title track, marcia plumbea e malinconica in cui la nuova sezione ritmica ha subito l’occasione di mettersi in mostra, grazie a un bilanciamento dei suoni che li fa risaltare forse anche più del necessario. L’intermezzo centrale, più inquieto, accompagna Amleto nel suo piano di vendetta, screziandosi di una certa solennità dilatata e crepuscolare nel solo, mentre l’ultimo quarto torna alla durezza tesa e malinconica già trovata in apertura, con un finale solenne su cui cala idealmente il sipario dell’opera shakespeariana. La successiva “Conqueror”, la più breve del lotto, incede su ritmi tesi e grezzi, lasciandosi andare quasi subito a una digressione strumentale dal retrogusto esotico prima di tornare in riga in tempo per l’ultima strofa, ancora nobilitata dalla chitarra ipnotica di Shelton. Una sirena d’allarme apre “Never Again”, traccia delicata e scorrevole in cui i timori di una guerra nucleare si fanno strada tra arpeggi pensosi che, improvvisamente, cedono il passo a chitarre incombenti. “The Arena” suona la carica, alzando i ritmi per consegnarci una traccia di heavy metal crudo e incalzante, la cui fosca ripetitività riecheggia la dura vita dei gladiatori romani, perennemente accompagnati dal cozzar di lame. L’intermezzo strumentale che apre la seconda metà arriva come una manna dal cielo, spezzando la snervante meccanicità del pezzo con un passaggio più rilassato ma non privo di una nota di minaccia. Un arpeggio languido apre “In the Wake”, power ballad dal sapore introspettivo che si distende tra melodie intimiste e rapidi indurimenti, di volta in volta robusti o inquieti, che trovano compimento in un climax finale che si colora di eroismo. Un’intro sulfurea ci dice che è giunto il momento di “The Talisman”, brano arcigno e cupo ma, in ultima analisi, un po’ canonico, mentre la successiva “The Other Side” torna ad alternare melodie languide a brevi e minacciose sfuriate. Anche qui i tempi si mantengono quadrati, incombenti, anche se col procedere del minutaggio la traccia si carica di una certa foga battagliera. “Castle of the Devil” torna a snocciolare riff duri e minacciosi, per una traccia pesante dal retrogusto quasi doom in cui solo di tanto in tanto si vedono spiragli di luce. Con “Ghost Warriors”, ispirata alla figura di Arminio e alla celebre battaglia di Teutoburgo, si molla il freno, seppur di poco, per indulgere in ritmi meno oppressivi – sempre guardati a vista, però, dai cupi rallentamenti sparsi qua e là che mantengono l’atmosfera della traccia appena conclusasi – e melodie dal profumo blueseggiante, che donano alla composizione un retrogusto intrigante e leggermente fuori dagli schemi. Chiude l’album, introdotta dal solismo frenetico dello Squalo, “Blood Island”: l’ultima frustata del quartetto del Kansas, tutta giocata su ritmi tesi e combattivi, dispensa ampie dosi della carica incalzante che già abbiamo incontrato e chiude in modo degno ma senza fuochi artificiali un lavoro imponente, strutturato, impegnativo e classicamente Manilla Road.
Come scrivevo all’inizio, “To Kill a King” va digerito con calma, per essere interiorizzato pian piano: la sua eccessiva lunghezza potrebbe essere uno scoglio difficile da superare, soprattutto all’inizio, ma il tiro è sempre quello giusto, quello epico e grezzo che i Manilla Road non hanno mai smesso di diffondere, e serpeggia lentamente sottopelle di ascolto in ascolto, crescendo pian piano. Non sarà “The Deluge”, ma non sono molti i gruppi che possono sfornare un lavoro così alla posizione numero diciotto della propria discografia.
Grazie di tutto, signor Shelton.
Ci mancherà.