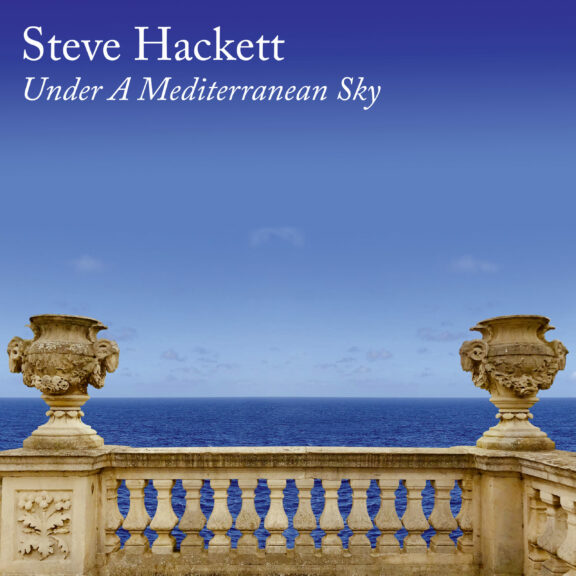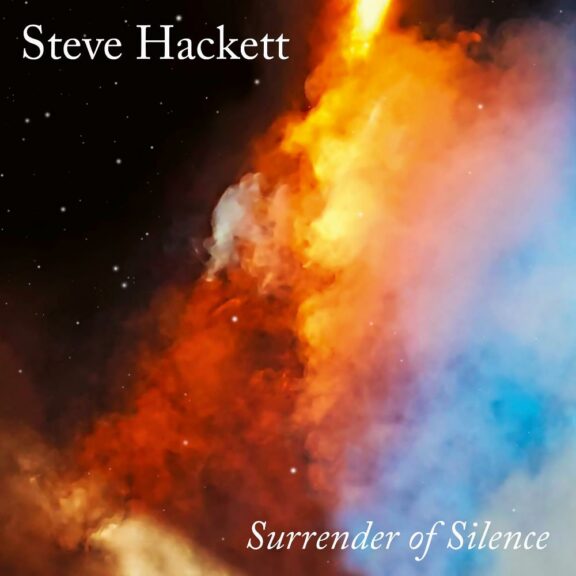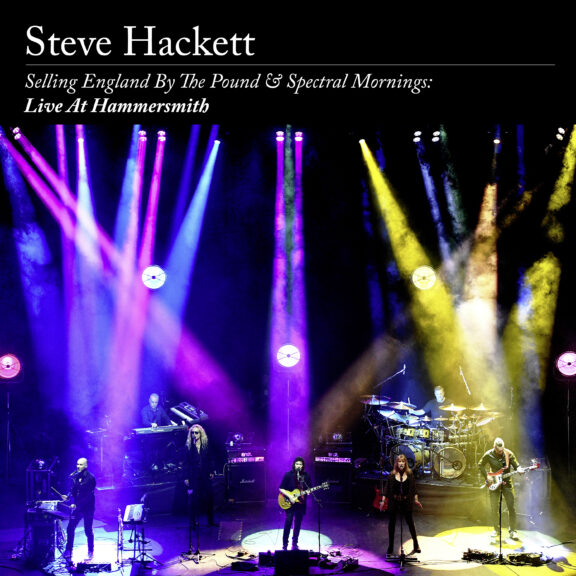Recensione: Under A Mediterranean Sky

“[…] Ma, all’infuori di questo dramma, credo che tutti i problemi posti dal Mediterraneo siano di un’eccezionale ricchezza umana, e che interessino, quindi, storici e non-storici. Penso anche che gettino luce sul presente, che non siano sprovvisti di quella utilità, nel senso più stretto, che Nietzsche esigeva dalla storia.
[…] Non era forse l’occasione propizia, impadronendomi di un personaggio fuori serie (il “Mediterraneo” ndr), di approfittare della sua massa, delle sue esigenze, delle sue resistenze e delle sue insidie, anche del suo slancio, per cercare di costruire la storia diversamente da come la insegnavano i nostri maestri?”.
Questo scrive Fernand Braudel, tra i maggiori storici di tutti i tempi, a proposito proprio del Mar Mediterraneo (di cui è il massimo studioso) nella prefazione alla prima edizione francese (1949) della monumentale e imprescindibile opera Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II.
Leggendo questi estratti, ma si potrebbe trarre ispirazione anche da un’altra sua opera intitolata Memorie del Mediterraneo, due domande sorgono lecite: cosa è stato il Mediterraneo? Cosa rappresenta? La risposta è una, univoca e inconfutabile: tutto! Piaccia o no, c’è un dato che suona terribile e intimidatorio nel mondo della cultura e dell’arte: chiunque si approcci al Mediterraneo rischia desolatamente di imbattersi in una titanica impresa che può, data la complessità del tema trattato, rivelarsi fallimentare. Com’è noto esistono però delle eccezioni che “sconfessano” le regole e questi slalom tra i paletti dell’impossibile possono essere condotti esclusivamente se si appartiene a una ristrettissima élite di eletti giganti che, per dirla alla Newton, caricandosi sulle spalle in piedi i comuni mortali allargano orizzonti e limiti visivi.
Un gigante della Musica (esattamente con la “nasale bilabiale” maiuscola) ha osato affrontare il Mediterraneo e ha regalo all’umanità, senza esagerazione, un disco di livello assoluto, tra le massime espressioni musicali di tutti i tempi e, a livello trasversale, di tutti i generi; un disco che stupendo torna a colpire divenendo icona non solo di un’epoca, ma di tutto un genere artistico; un lavoro musicale la cui esagerazione totale è capace di far sorgere esigenze psicanalitiche nell’ascoltatore. Il gigante in questione è Steve Hackett con la sua ultima fatica: Under A Mediterranean Sky.
Con questo album il chitarrista inglese dimostra di essere un musicista in continua evoluzione, nonostante età anagrafica e numero di album (questo è il 27^ in studio) potrebbero legittimamente relegarlo a una dorata pensione, capace di raggiungere vette dove si respira la rara aria della grandezza e della solennità. Hackett si autoconsegna alla Storia con un disco la cui bellezza, eleganza, tecnica, particolarità e tutto quanto si possa aggiungere, raggiungono livelli eccelsi, probabilmente intoccabili anche soltanto con il pensiero. Stupisce il mondo dando vita a un affascinante lavoro mai sentito prima: ricco di idee, coerenza, tocchi di gran classe, ambientazioni sublimi, emozioni e pathos tali da renderlo eccelso da ascoltare, inumano da immaginare, impossibile da ripensare e per sempre da ricordare.
Con Under A Mediterranean Sky il genio di Steve Hackett, si spinge oltre le colonne d’Ercole, si muove al di là dei limiti del conosciuto e del possibile, naviga mari mai navigati (e l’allitterazione in “m” ed “n” non è casuale), ma per lui tutto ormai è possibile consentendo anche la materializzazione di questo capolavoro celato nelle profondità più recondite della sua genialità.
Qui il compositore e il musicista si mescolano puntando la bussola della navigazione verso la meraviglia e lo stupore e portano l’ascoltatore in dimensioni “meta”, dove diventa reale l’esplorazione di mondi dove la musica diventa una naturale estensione del cuore.
Under A Mediterranean Sky quindi si delinea come un “saggio di geografia della Musica” in quanto le note abilmente e magistralmente elaborate da Hackett toccano, con una forte “caratterizzazione caratteristica”, la Grecia, la Spagna, l’Italia, il Medio Oriente, Malta.
Proprio alla città maltese di Mdina è riservata l’apertura, di rara bellezza, del disco; un brano epico, sontuoso e le cui caratteristiche, che saranno una costante dell’intero lavoro, gli consentirebbe di diventare a pieno titolo la colonna sonora di Ben Hur, il kolossal per antonomasia. Questa medesima sensazione la si prova anche udendo l’inizio epico della stupenda Sirocco. Ascoltando Mdina inoltre si ha chiara la ratio che ha spinto Hackett a scegliere la foto di copertina, un chiaro tributo ai meravigliosi palazzi che a Malta trasudano storia, nobiltà, bellezza e fascino. Quindi un arcano si svela: il collegamento inequivocabile tra il titolo del disco, la cover e le atmosfere che nel corso del disco saranno evocate e svelate.
L’ascolto dei brani consente all’ascoltatore di ritrovare la pace interiore e dei sensi, la musica stimola la meditazione, ma in alcuni passaggi i temi orchestrali, per pomposità e bellezza, incutono timore, fanno crescere forte l’emozione di un ascolto senza eguali.
Già dopo l’ascolto dei primi due brani si ha netta la sensazione di un chitarrista nato, cresciuto e sedimentato nell’alveo del Mediterraneo, in quei luoghi che suona e le cui note inequivocabilmente evocano; assurdo come Hackett sia riuscito a calarsi nel determinismo geografico delle terre che suona con la sua chitarra.
Talvolta si ha la percezione che la sua chitarra non suoni, ma che parli direttamente al cuore di chi ascolta, come si può facilmente evincere dall’ascolto di Adriatic Blu e Joie De Vivre.
In questo album nulla è lasciato al caso, tutto è studiato nei minimi dettagli, a partire dalla giusta durata dei singoli brani e dell’intero lavoro, fino ad arrivare a quei velati dettagli che rimandano ad altre opere. A prova di ciò si pensi agli armonici collocati nella parte finale di The Memory Of Mith, che rappresentano una forte eco del celebre brano, sempre di Hackett, Horizons, o i rimandi in apertura e chiusura, quasi a voler conferire una struttura circolare all’intero disco che metaforicamente potrebbe far pensare alla partenza e al ritorno di questa lunga navigazione nel Mediterraneo, ad alcuni passaggi (con le dovute mediazioni e consci di livelli compositivi completamente differenti) del celebre The Guitar Trio (reunion dell’altro capolavoro Friday Night In San Francisco) di Al Di Meola, John McLaughlin e Paco De Lucia. Qui diventa suggestivo il parallelismo (trattasi di un omaggio?) con l’altra meraviglia dedicata al Mediterraneo suonata dal fenomenale trio, cioè Mediterranean Sundance, brano di Al Di Meola. Rimanendo nel solco tracciato dai rimandi interessante è notare come Steve Hackett torni con un album acustico e strumentale 12 anni dopo Tribute in cui omaggia i maestri del passato, tra cui Andrés Segovia qui ripreso, a mo’ di laudatio, dalla meravigliosa Andalusian Heart.
Ascoltando il disco dall’inizio, come detto, ci si imbatte in Mdina (The Walled City) che può senza dubbio avvicinarsi a una rappresentazione (in forma ovviamente ridimensionata) di un concerto per chitarra e orchestra. L’apertura trionfale è affidata alle percussioni, ai brass e a tutte le sezioni degli string. Il tutto è programmato e suonato (nonché registrato e missato) dal maestro Roger King, già pianista in altre collaborazioni con Steve Hackett. Si accenna a un tema che fa venire la pelle d’oca nella sua esposizione e che ricorda, per certi versi, alcuni guizzi eroici contenuti in Feeding The Wheel di Jordan Rudess (del 2001). L’orchestra si blocca e lascia spazio ad Hackett che irrompe con accordi in rasgueado e una scala discendente che sa tanto di Joaquín Rodrigo. Dopo vari arpeggi ostinati (tipici del chitarrista inglese) vi è una fase comunicativa con la sezione dei legni e una successiva “fase di cadenza”, come a ristabilire l’ordine di un caos magnifico da lui stesso generato. I virtuosismi chitarristici conducono al minuto 03:50 dove lo stesso Hackett delizia le orecchie con delle melodie armonizzate per sesta di incredibile fattura. Queste ultime fanno da apertura a una nuova fase orchestrale, che riprende il tema principale iniziale. L’opener di Under A Mediterranean Sky è senza dubbio un magnifico biglietto da visita e si è soltanto all’inizio.
Hackett è famoso anche per essere musicista poliedrico e un cultore della musica a 360 gradi, sorprenderanno quindi le sonorità più sciolte e frivole insite in Adriatic Blue. Le scale in legato discendente sono dei guizzi di passione, la tecnica qui è al servizio della musica in ogni singolo passaggio e i più attenti non potranno non notare l’incredibile stato di grazia dell’ex Genesis che mostra da subito una tecnica davvero invidiabile. È incredibile quanto riesca a passare velocemente attraverso linguaggi musicali apparentemente diversi per epoca e periodo storico. Passaggi e innesti mai forzati, complice ovviamente la conoscenza in materia di modulazione e arrangiamento. Al minuto 02:03 infatti cambia completamente registro e da qui più volte fino al finale in reprise.
Intro imponente costruito su una progressione di accordi diminuiti per Sirocco. Timidi strings accompagnano Steve Hackett che si cimenta sulle note acute con la tecnica dell’appoggiato a calcare la teatralità della song, ma dopo nemmeno 2 minuti ci si ritrova nel deserto del Sahara immersi in una danza etnica avvolgente. Il tema è costruito sul Frigio di Dominante che enfatizza gli intervalli più caratteristici e distintivi e il tutto è accompagnato da elementi percussivi (programmati) che contribuiscono a rendere vivo il paesaggio nel nostro immaginario. Qui c’è la collaborazione di Malik Mansurov al tar (strumento tipico persiano a corde). Il tocco di classe è nel finale, dopo la chiusura orchestrale le dita di Steve Hackett sembrano “non volersi fermare”.
Joie de Vivre è un vortice di arpeggi, ostinati e continui che a tratti, come per magia, sfociano in quel fantastico tema principale di Classical Gas di Mason Williams, che come noto è un brano a cui Hackett è molto affezionato e che spesso ha riproposto dal vivo in varie versioni.
A seguire c’è The Memory Of Myth, con l’ingresso al violino di Christine Townsend, collaboratrice storica di Hackett. Ancora una volta gli arpeggi ostinati di Hackett la fanno da padrone dopo un gioco di armonici naturali che per certi versi, come già detto, sono da sempre il suo marchio di fabbrica. Verrebbe da dire che questi ultimi due brani rappresentano la parte più oscura dell’intero Under A Mediterranean Sky, una sezione emotivamente impegnativa all’ascolto.
È la volta di Scarlatti Sonata, un tributo al grande compositore italiano Domenico Scarlatti (1685-1757) e unico brano già edito dell’intero disco. Curioso come il titolo sia semplicemente “Sonata” quando come ormai è noto si tratta della Sonata in Mi Minore K. 11 (L352), ovvero una trasposizione piuttosto celebre per chitarra (a sua volta) della Sonata In Do Minore K. 11 (L 352) per tastiera (da notare appunto il termine “tastiera”, si è nel periodo in cui il pianoforte, come unanimamente conosciuto, non è ancora così diffuso). La versione di Steve Hackett è senza dubbio molto influenzata da quella sicuramente più celebre di Andrés Segovia (1893-1987), già citato in precedenza. Molte “licenze interpretative” di quest’ultimo sono state dunque interiorizzate dal nostro englishman infatti, come nella versione appunto di Segovia, vi è una notevole dilatazione nel tempo tra le battute 5 e 8 (da partitura) e la stessa cosa si ha nel finale del primo movimento (movimento attentamente ritornellato da Steve Hackett, contrariamente a Segovia sempre come da partitura), a sottolineare il fatto che qui si vuole esaltare la tradizione della chitarra classica, compreso forse il suo più grande interprete di sempre. I tagli emozionali però vanno ben oltre, la scelta dei diversi timbri (più buca o più ponticello a seconda del momento) e il lirismo di fondo ci mettono al cospetto di un talento della sei corde davvero fuori dal comune.
Segue Casa del Fauno, struggente brano accompagnato da degli string che riportano a composizioni tradizionali inglesi, dove il tema è così drammaticamente ispirato da stamparsi nella mente dell’ascoltatore per sempre anche dopo un solo ascolto. In questo brano si ascolta eleganza allo stato puro. L’ingresso alla sei corde è molto raffinato nella sua semplicità, una ballata popolare d’altri tempi che vede la partecipazione del fedelissimo John Hackett (fratello di Steve) al flauto. Dunque brano alquanto breve ma intenso, che lascia spazio a The Dervish And The Djin. Qui si ascolta un intro di impatto orientale dove troviamo Rob Townsend al sax soprano, nuovamente Malik Mansurov al tar e Arsen Petrosyan al duduk (strumento armeno a fiato, simile per certi versi a un flauto). Un organico di questo calibro genera un viaggio sonoro che ha dell’incredibile, si naviga di continente in continente, di epoca in epoca, ma il tutto è dannatamente piacevole e mai stucchevole. Il livello compositivo di questo full-length, interamente a opera di Steve Hackett, Jon Hackett e Roger King (eccezion fatta per l’opera di Scarlatti) è di livello altissimo.
Qui si celebra, come già scritto, la Musica con la M maiuscola e proprio a conferma di questo assistiamo alle prime note del successivo brano strumentale. Di Lorato è incantevole l’ingresso con le sue atmosfere simil rinascimentali, probabilmente è destinata a diventare un classico nel repertorio di Hackett in quanto a impatto emotivo, tecnica, gusto e soprattutto “durata” è esemplare. Infatti il brano rappresenta l’evoluzione perfetta del tipico brano strumentale guitar solo, sia come intermezzo sia come opera “che brilla di luce propria”, basti pensare alla notissima Horizons. In questo brano si ascolta lo Steve Hackett che tutti conoscono, nelle sue incursioni barocche e nei ritardando che da sempre lo contraddistinguono.
Andalusian Heart è struggente, Hackett è alle prese con una chitarra che duetta con l’orchestra in maniera assolutamente naturale e profonda. Il break di cadenza sulla dominante è ispiratissimo (a confermare la tonalità d’impianto) e contiene dei passaggi in arpeggio mozzafiato tecnicamente molto impegnativi. Al minuto 04:32 l’orchestra rientra con un finale di botto, Steve Hackett qui è all’apice della sua forma interpretativa. C’è di tutto, un’immersione totale nel linguaggio andaluso e uno sguardo alla musica “colta” sia per forma che per contenuto. Il punto forse più alto di un disco di livello spropositato. Da notare, come per le produzioni “serie” del settore classico sinfonico-orchestrale, la cura maniacale per le dinamiche degli strumenti (o sessioni intere di strumenti). Nell’ambito prog-rock c’è da ammettere che le dinamiche non sono proprio curatissime, soprattutto se prendessimo come standard le uscite contemporanee; qui il pp è pianissimo, il ff è fortissimo e così via. La chitarra di Steve Hackett, a differenza dei suoi dischi “elettrici”, potrebbe sembrare forse troppo sbilanciata indietro, ma è così che deve essere: si dimentica a volte che la chitarra classica è forse lo strumento che ha meno voce (vedi volume) tra tutte le altre famiglie di strumenti musicali. Qui il suo focus all’interno del mix del disco è ben coerente con la realtà. Ascoltare un concerto Chitarra e Orchestra (benché qui l’unica vera pecca è proprio il fatto che non ci sia una vera e propria orchestra) dove la chitarra ha lo stesso volume di una sessione fiati (ad esempio) è sicuramente sinonimo di scarsa competenza di produzione e mastering.
The Call Of the Sea chiude il concept strumentale, un viaggio incredibile ben rappresentato da questo brano dal sapore più sereno e soleggiato, un modo per Hackett di congedarsi in tonalità maggiore dopo un intro dal sapore più riflessivo e nervoso. La quiete dopo la tempesta dunque, anche se c’è spazio inizialmente per sfuriate (termine che poco si addice ma che forse lascia intendere la “fisicità” con cui si affrontano e vanno suonate alcune parti) chitarristiche in tonalità minore. Durerà il tutto quanto basta e qui il percorso del brano cambia pelle come già accennato in precedenza.
Questo disco, il cui ascolto fa paura e incute timore per quanto il genio umano è stato in grado di concepire, pone all’ascoltatore un problema molto serio e di non facile risoluzione: da questo momento in poi con “quali orecchie” si potrà ascoltare tutto il resto? Tutto, al cospetto di questo album che dovrebbe essere premiato a livello planetario, potrà apparire ridimensionato e insoddisfacente.