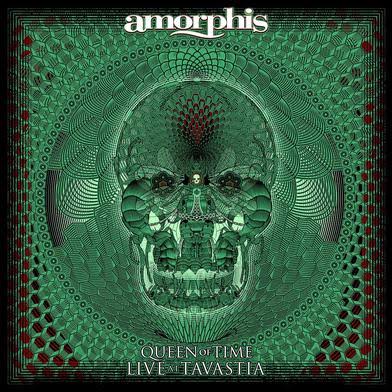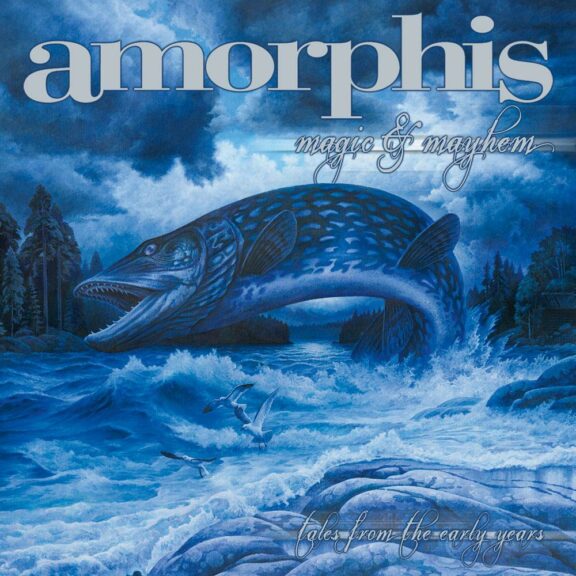Recensione: Under The Red Cloud
Realizzare dodici dischi in soli venti anni di carriera è una impresa per pochi, soprattutto in un periodo in cui le band, raggiunto il successo, rallentano la produzione. Ci sono solo due gruppi che, raggiunto il tetto del metal, non lo hanno fatto. Anzi, è dal cambio di millennio che buttano fuori un nuovo album ogni anno dispari. Una sono i Dream Theater, l’atra (più o meno) sono gli Amorphis. I primi bucheranno, dopo sei album spesi alla ricerca di nuove vie. Gli Amorphis invece dal 2006 sono intenti a diventare quanto di più lontani possibile dal concetto espresso dal loro stesso nome: i loro dischi, le loro canzoni, seguono oramai regole precisissime ed hanno dato vita ad album epici, dopo un paio di album, a tutti gli effetti, amorfi. Il che porta anche gli ultimi album ad essere molto simili tra loro, perché come si dice “squadra che vince non si cambia”. Squadra che vince non si cambia, e infatti anche gli attori sono sempre gli stessi, sempre quei sei.
Gli Amorphis però, avevano provato a rinnovarsi, due anni fa, con Circle. Ne era venuto fuori un buon disco, cui alla classica struttura della canzone Amorphis erano state aggiunte varie influenze, un po’ di black e un po’ di elettronica. Ora è la volta di Under The Red Cloud che, almeno in quanto a veste grafica si ripresenta simile.
La prima traccia, che per la cronaca è anche title track, sembra un deciso dietro front rispetto a quanto sentito nell’ultimo disco. Non si tratta di un brutto pezzo, pur tuttavia si tratta di un mero esercizio di stile, la riproposizione di tutti gli stilemi della canzone-amorphis tipica, Under the red Cloud avrebbe potuto essere tranquillamente un extra di Silent Waters o di Skyforger. Decisamente meglio The Four Wise Onse, aperta da chitarre a zanzara con un Joutsen maligno e autore di una prova da brividi. Un gran pezzo, che neppure un break melodico forzato e desolatamente banale (par incastrato lì a forza solo perché “nelle nostre canzoni il break deve esserci”) riesce a rovinare. Torna la normalità classica con le successiva Bad Blood, The Skull e Sacrifice, due pezzi ben calibrati, con una buona melodia e un buon contrasto di brutalità e decadenza languida, che come nel caso della opener non fanno gridare al miracolo.
Ottimi risultati invece in coda al disco – strano ma vero i nostri, che spesso ci hanno abituato a mitragliate di 5/6 hit a inizio disco, danno il meglio alla fine. Oltre alla già citata Enemy At The Gates, ottima e ispiratissima risulta essere Dark Path, con una strofa death cui fa contrasto il ritornello struggente e un break forse un po’ stucchevole, ma comunque ben inserito nella song. Ottima pure la folkeggiante Tree of the ages, altro pezzo bomba, mentre la suggestiva White Night, oscura, malinconica ed impreziosita dalla voce femminile, conclude il disco splendidamente, non riuscendo però a fugare completamente i dubbi sulla dodicesima fatica dei finnici. Anche in questo caso però, pur registrando interpretazioni ispirate, è davvero difficile sbarazzarsi della sensazione di già sentito che permea gran parte del disco.
Insomma, gli Amorphis, in buona sostanza e senza giri di parole, sembrano stanchi e poco ispirati, come era accaduto, a mio modo di vedere in The Beginning of Times. Unico a non annoiarsi pare essere Tomi Joutsen, tanto che questo disco può essere visto, sotto certi aspetti, come un canto del cigno (nel senso che Jout significa Cigno). Il cantante prodigio sfodera quella che, molto probabilmente, è la sua prova migliore alla guida dei finlandesi. Ancora più che in Circle svaria dal growl death, allo scream black fino alle consuete prove intense e sofferte di clean. Da un senso a diversi brani, cambia radicalmente una normale song degli Amorphis semplicemente grazie alla sua prova magistrale. Soprattutto, oltre alla già citata The Four Wise Ones, riescono molto bene anche Death of a King, Enemy At the gates, che fra l’altro si segnalano per un tentativo di recupero, peraltro riuscito,delle sonorità di Elegy.
Ciò non ostante, come diceva un’altra band, che dodici dischi però non li ha fatti, The song remains the same. Under the red Cloud ci consegna una band con le polveri un po’ bagnate, che combatte contro la formula che l’ha resa vincente dal 2006. Inanella una serie di composizioni impeccabili quanto godibili, eppure molte di queste risultano fredde e poco ispirate. A volte mette del suo per insaporire la ricetta, ma non ci riesce particolarmente, in Circle, ad esempio, il risultato era stato migliore. Gli sforzi però aiutano, il resto lo tiene in piedi un cantante eccezionale, qui protagonista della sua miglior prestazione in quanto a versatilità. Viene fuori un disco povero di idee, come lo era The Beginning of Times (e che il mio illustre predecessore perdoni una sì netta divergenza di pensiero da quanto scrisse al tempo), un disco ricco di contorni e belle sfumature, con quattro pezzi in cui l’antica classe brilla inottenebrata. Ci sono band che, al dodicesimo disco, sono messe molto peggio.