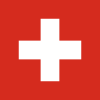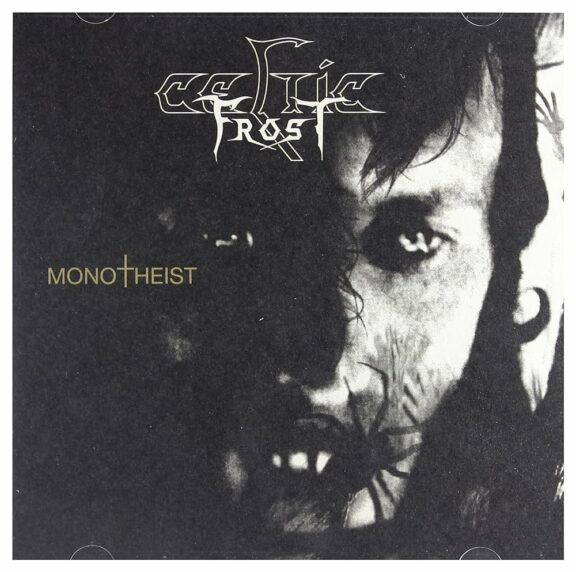Recensione: Vanity / Nemesis
“Cole Lake” viene registrato nell’estate berlinese del 1988 e pubblicato a Settembre, “Vanity / Nemesis” occupa l’inverno dell’anno successivo, per poi arrivare nei negozi solo ad Aprile del 1990, una gestazione più ponderata e complessa, ed una elaborazione in studio avvenuta durante una stagione diametralmente opposta a quella di “Cold Lake“, tanto metereologica quanto personale e psicologica della band. Verrebbe facile dire che il disimpegno di “Cold Lake” trova una sua rispondenza nei mesi estivi che lo hanno visto protagonista, mentre di contro “Vanity / Nemesis” rispecchia un tentativo di recupero di serietà e rigore da parte dei Frost; casualità o meno che sia, il simbolismo si presta abbastanza bene ad introdurre la sesta release della formazione elvetica, giunta ad un momento spartiacque della propria carriera. “Vanity / Nemesis” è l’album che decide il futuro della band, superare il momento no o morire, tertium non datur. “Cold Lake” è stato accolto come un flagello da stampa e pubblico, una manciata di canzoni in viola è bastata a spazzare via quanto di buono prodotto dalla band in anni ed anni di onorata (e lodatissima) carriera. Possibile che l’ennesima sperimentazione musicale sia stata letta solo e soltanto un tradimento anziché come un ulteriore (e coerente) passo nella incessante ricerca di nuovi territori da parte di una band che ha fatto di questo il suo tratto fondante e caratterizzante più autentico e viscerale? A malincuore Thomas Gabriel Warrior deve ammettere che è così, “Cold Lake” non viene percepito come una sfumatura in più nella tavolozza pittorica dei Frost ma come l’onta che non doveva essere inflitta ai fan. Warrior si conforma, finisce col convincersene pure lui e rimugina su come rimediare alla frittata.
La figurina di Martin Eric Ain in copertina e nei credits pare già un buon biglietto da visita per stemperare gli animi (per quanto si limiti a suonare effettivamente nella sola “The Heart Beneath” e a fare le backing vocals a scampoli); in concreto il basso è affidato quasi interamente a Bryant ed episodicamente a Warrior in “Phallic Tantrum” (pare un po’ la pantomima dei Kiss di fine anni ’70 con Ace Frehley). L’immagine – da ricostruire – è importante, il tassello Ain ne è una parte, poi va ripensato il guardaroba della band, va immaginato un artwork e delle photosession più dignitose di “Cold Lake“, e soprattutto va composto un album che cambi rotta rispetto alle civetterie e agli ammiccamenti sleazy rock costati carissimi ai Celtic Frost. Il rislutato finale di tutto questo gran lavorìo diventa “Vanity / Nemesis“, un titolo che pare fare autocritica, riflettendo sulla nemesi causata da un eccesso di vanita (in realtà si tratta di un titolo composito declinato in due tracce distinte all’interno della scaletta). Immaginando per un attimo che “Cold Lake” non fosse mai stato pubblicato e che quindi “Vanity / Nemesis” fosse il lavoro immediatamente successivo a “Into The Pandemonium“, credo che l’audience non lo avrebbe accolto in maniera particolamente calorosa. Sarebbe risultato comunque un arretramento rispetto all’avanguardia del Pandemonio. “Vanity / Nemesis” si attesta come un album di heavy metal tutto sommato abbastanza quadrato (e squadrato), privo della ferocia iconoclasta e necrofila dei dischi pubblicati sino al 1985, ma privo anche del pionierismo, dell’innovazione e di quel senso di scoperta che aveva permeato l’allora inimmaginabile “Into The Pandemonium“. Il merito di “Vanity / Nemesis” diventa quasi esclusivamente quello di aver messo una pezza al fuori pista di “Cold Lake“, un orizzonte talmente drastico e grave da richiedere qualcosa di sobrio e ortodosso, una prova di fede, anche a patto di non ottenere in dote l’ennesimo capolavoro che sarebbe stato lecito aspettarsi da una band del valore dei Celtic Frost. Chi si accontenta gode insomma e, sebbene le critiche non manchino neppure in questa occasione, perlopiù è tutto un tirare sospiri di sollievo per aver evitato il peggio, la disfatta finale e insozzata di vergogna.
Per me “Vanity / Nemesis” è sempre stato qualcosa di più della semplice medicina alla “crisi” d’identità dei Frost. E’ trascorso più di un lustro dall’esordio su vinile con “Morbid Tales“, sei anni intensissimi nei quali la band ha concentrato una creatività esplosiva ed incontenibile (di cui anche “Cold Lake” è espressione, nonostante il broncio dei fans), ridurre “Vanity / Nemesis” a mero sciroppo correttivo sarebbe ingiusto ed ingeneroso nei confronti dei Frost. Nessun loro album è nato per caso, con faciloneria o mero opportunismo, perlomeno non nella prima vita della band (come è noto torneranno sulle scene nel 2006 con “Monotheist“, per poi litigare e filiare i Triptykon del solo Warrior, prosecuzione che riprende le fila del discorso interrotto con “To Mega Therion“). Il testamento discografico – più o meno consapevole – dei Celtic Frost dell’era ’84 – ’90 si configura come una specie di summa e compendio della strada percorsa sino a quel momento, punto di incontro dei vari affluenti che hanno ingrossato il sound della band, giunto ad una maturazione di un profilo artistico che colloca i Frost nel loro tempo, all’alba di un nuovo decennio che sarà piuttosto impegnativo (a tratti mortificante) per l’heavy metal così come era stato concepito negli ’80s. Il primo segno di vita di Warrior sull’album è il suo consueto “Uh!“, che ci rassicura sulla familiarità dei nostri; segue un lotto di pezzi i quali, come detto, non intendono sconquassare valli e montagne, né andare a scoprire chissà quali lande inesplorate, quanto semmai catalizzare l’esperienza della band e metterla al servizio di un disco di heavy metal classico e disciplinato (nei limiti in cui i Celtic Frost possono essere “classici” e “disciplinati”). A pensarci bene, del puro heavy metal i Frost non lo avevano mai fatto, dunque dopo aver toccato con mano e riletto a modo loro l’hard rock (comunque debitamente metallizzato) con “Cold Lake“, è il turno del metal nudo e semplice, un’altra puntata del programma di divulgazione scientifica “Come i Celtic Frost fanno proprio un altro genere musicale“.
A ben vedere, non tutto è così inquadrato e schematico, perché in effetti mentre un brano come “Vanity“, ad esempio, mantiene il cordone ombelicale con “Cold Lake“, “A Kiss Or A Whisper” è ingrugnita parecchio; “The Wings Of Solitude“, con voce femminile a corredo, ha una sua eccentricità e bizzarria, anche e soprattutto in fase di chorus; “Nemesis” ipnotizza con un riffing a tratti circolare. C’è poi una cover di Brian Ferry (“This Island Earth“), non proprio banale in ambito heavy metal, che con la sua lamentosa indolenza si trasforma in una specie di out-take perfetta di “Into The Pandemonium, e del resto nell’EP “Wind In My Hand (Third From The Sun)“, che anticipa l’album e fa circolare il singolo estratto dal full-length, in scaletta troviamo un remake di “Heores” di David Bowie, piuttosto stravolta e sui generis, oltre alla splendido inedito “A Descent To Babylon” che purtroppo non finirà nella scaletta di “Vanity / Nemesis” (ma che verrà poi recuperata nella compilation di chicche varie “Parched With Thirst Am I And Dying” del 1992). “The Heart Beneath” nella sua semplicità è un pezzo esplosivo ed apre magnificamente il disco, belle anche “Wine In My Hand“, “The Restless Seas“, “The Name Of My Bride“… ma francamente a mio gusto e parere il platter offre una scaletta piuttosto omogenea qualitativamente ed interessante nella sua interezza. Come detto, saranno in molti a ritenerlo deludente e certamente è innegabile che rispetto ai tempi di “Morbid Tales” e “Emperor’s Return” questi Celtic Frost siano più miti e riflessivi, senza bava alla bocca. Tuttavia se si comprende che l’intera parabola della band non può esaurirsi a singoli album ma va considerata nella sua totalità, si avrà forse più chiaro che i Frost hanno fondamentalmente cambiato schema di gioco ad ogni partita, come spesso fanno i grandi ed irrequieti geni artistici (si pensi a Stanley Kubrick, il quale ad ogni film ha manipolato un diverso genere cinematografico, senza che nessuno gli abbia mai rimproverato di non essere rimasto coerente col precedente o, peggio, di aver “tradito”).
Nonostante tutte le considerazioni espresse, “Vanity / Nemesis” non basta a tenere viva la fiamma dei Frost, troppo ammaccati dalle botte ricevute per “Cold Lake“, instabili nella line up, investiti pure loro dai cambiamenti nel music business e, in definitiva, stanchi e demotivati. Il loro cammino si arresta, anche se per un paio di anni ancora il videoconcerto “Live at The Hammersmith Odeon 3.3.89” (nel quale una scaletta monstre mette assieme “The Usurper” con “Seduce Me Tonight“, “Cherry Orchards” con “Into The Crypts Of Rays“, qualcosa di indigeribile per i fans più integralisti) e la su menzionata compilation “Parched With Thirst…” mantengono il monicker in stato di coma vigile. Col senno di poi, trascorsi quasi 30 anni dalla sua pubblicazione, dovrebbe essere più semplice restituire ai Celtic Frost l’onore delle armi, riconoscendo a “Vanity / Nemesis” il titolo semplice e schietto di bell’album; magari non il loro capolavoro ma d’altra parte pure il loro disco più sottovalutato e minimizzato. Spiace che in occasione di “Monotheist” la band abbia fatto finta di non ricordarsi pure di questo album (oltre ovviamente che del blasfemo “Cold Lake“), concentrandosi esclusivamente sul nero pece degli esordi, andando penitente incontro ai desideri della propria fan-base e mettendo un po’ in sordina quell’indole bastian contraria che invece aveva fieramente sfoggiato in passato.
Marco Tripodi