Recensione: Victorious
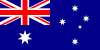
I Wolfmother appartengono a quella schiera di gruppi comparsi sulla scena musicale agli albori del nuovo millennio e capaci di destare una certa attenzione saccheggiando e mescolando il repertorio di alcuni mostri sacri dell’Hard Rock (Led Zeppelin, Black Sabbath). Fra le tante nuove band che si contraddistinguono per questo sound derivato (The Answer e Bigelf, solo per citarne alcune), i ragazzi australiani non sono propriamente i più amati dai puristi del genere; ma d’altro canto sono quelli che hanno riscosso maggior successo dal punto di vista commerciale. Si stima che con l’esordio omonimo abbiano venduto un milione e mezzo di copie nel mondo, hanno ricevuto complimenti illustri, partecipato a tour importanti, hanno vinto pure un Grammy ed è praticamente impossibile non averli ascoltati, per scelta, oppure in via indiretta da qualche altra parte: spot, videogiochi, serie tv e film. Non a caso, chiusa la parentesi garage ed indipendente del terzo album “New Crown”, per “Victorious” si sono potuti permettere di tornare in studio ad Hollywood, questa volta con il produttore Brendan O’Brien (Bruce Springsteen, AC/DC). Tuttavia, i continui cambi di formazione indurrebbero ormai a considerare i Wolfmother come una sorta di one man band, se non addirittura come il progetto solista del loro deus ex machina Andrew Stockdale. In effetti è lui ad avere l’esclusiva sul processo compositivo e sono sue quasi tutte le registrazioni (con il bassista ad incidere solo le parti di tastiera e quelle di batteria affidate a dei turnisti). Il monicker, comunque, gode ancora di buona popolarità. Tant’è che la scelta di raffigurare in copertina (per la prima volta) un lupo, sembra sottolineare la volontà di essere immediatamente riconoscibili. A proposito, l’artwork era stato rilasciato in bianco e nero come anteprima per il web, invitando i fan a personalizzarlo colorandolo. Attività che pare essere l’ultima moda in quanto ad anti-stress per adulti. E c’è da dire che già il titolo del secondo album “Cosmic Egg” aveva a che fare con lo yoga. Per quelli meno sofisticati, evviva, c’è sempre la musica.
L’immediata “The Love That You Give” apre l’album con il piglio giusto e genera aspettative che le tracce seguenti, purtroppo, non sapranno mantenere. Sia chiaro, non mancano i consueti marchi di fabbrica: hook accattivanti, chitarre vorticose, break onirici e voce ipnotica. Così come è possibile trovare altri pezzi godibili, tipo “Gipsy Caravan”, uno Stoner in stile anni ’70, o la stessa “Victorious”, ruffiana, ma non troppo, e con uno stacco à la Tony Iommi. In generale, però, matura presto l’impressione che il lupo si sia imborghesito ed abbia perso l’istinto selvaggio. Rasentano la decenza i brani che rispondono al nome di “City Lights”, la classica canzone che ti aspetti da uno andato a vivere in America, e “Best of a Bad Situation”, molto segnata dall’influenza dei Boston. Il resto si divide poi fra trascurabili filler e passaggi completamente a vuoto come “Baroness” e, soprattutto, “Pretty Peggy”: un momento acustico e con voce “al naturale” che nelle intenzioni, probabilmente, avrebbe voluto ricreare le atmosfere Folk di “Going to California” dei Led Zeppelin ed invece finisce per essere tanto banale da somigliare a qualcosa dei Coldplay (ok, l’ho detto). L’esperimento è discutibile al punto che ha forse il merito di alleviare l’effetto déjà-vù causato dalle altre tracce ed aiuta a convincersi che, in fondo, le chitarre distorte a ripetizione e la voce costantemente sovra-incisa non sono poi così male.
Il disco fatica comunque a scorrere, nonostante duri solo trentacinque minuti e venti secondi; e se per caso ci riesce, non monopolizza mai l’interesse dell’ascoltatore. Restando sospeso a metà fra la voglia di attenersi alla lezione dei maestri e magari il desiderio di svoltare verso orizzonti diversi. Infatti, più che i miti del passato, in alcuni frangenti Andrew Stockdale ricorda francamente Jack White (White Stripes). E non è da escludere che il suo sogno nel cassetto sia sentir intonare qualche pezzo dei Wolfmother negli stadi di mezzo mondo. Cosa, per carità, più che legittima. Ma se così fosse, bisognerebbe valutare questo lavoro in base alle reali possibilità che al suo interno via sia una hit ed il giudizio finirebbe per essere impietoso. Per fortuna, sono semplici supposizioni. Anche se, volendo, non c’è da penare per trovare elementi a supporto di alcune idee. Ad esempio, a proposito del brano che dà il titolo all’album, il leader dei Wofmother ha dichiarato di aver cambiato il testo originale “we will be victorious” in “she will be victorious”, affinché non sembrasse direttamente incentrato su qualche nemico… Ma che bravo ragazzo!? Sarebbe più accettabile immaginare che la modifica del verso si sia resa necessaria perché già presente in “Uprising” dei Muse. Altrimenti, con un po’ di fantasia, si dovrebbe iscrivere Andrew Stockdale al club degli artisti che, trovandosi al posto di Jim Morrison all’Ed Sulllivan Show, avrebbero di certo assecondato le richieste dei ben pensanti; e non per mancanza di carattere, ma, cosa ancor più preoccupante, perché sicuri che il successo si possa programmare seduti a tavolino. Il Rock, per fortuna, è un’altra cosa. E quando si vuole piacere a tutti i costi, si finisce spesso per non piacere più a nessuno.
Stando ai proclami, “Victorious” avrebbe dovuto rappresentare un ritorno trionfale, il miglior modo per celebrare il decennale del folgorante debutto sulle scene. Stando ai fatti, invece, non si tratta per niente di una “vittoria”. E’ al massimo un pareggio, sufficiente a mantenere la band in scia per un altro po’, in attesa che l’ispirazione torni quella di un tempo. Purtroppo, Mister Wolfmother qui non risolve problemi: dalla prevedibilità dei testi, all’assenza di quella vitalità in grado di scacciare la monotonia, passando per la sensazione che tutto sia stato fatto con eccessiva fretta. Nemmeno una produzione nel complesso positiva può camuffare più di tanto le ombre che cominciano ad affacciarsi, mentre si dissolvono le ultime luci riflesse del passato. In estrema sintesi, Andrew Stockdale sembra quasi vittima del suo stesso egocentrismo artistico. E, da questo punto di vista, potrebbe non essere casuale che tra i pezzi migliori ci sia l’unico che gli è capitato di comporre a quattro mani (“Gipsy Caravan”, scritto appunto con Kram degli Spiderbait). Quindi, più che insistere con il comportamento da lupo solitario, dovrebbe forse ritrovare la coerenza, il carisma, la fierezza del capobranco e rimettere insieme un vero gruppo.


