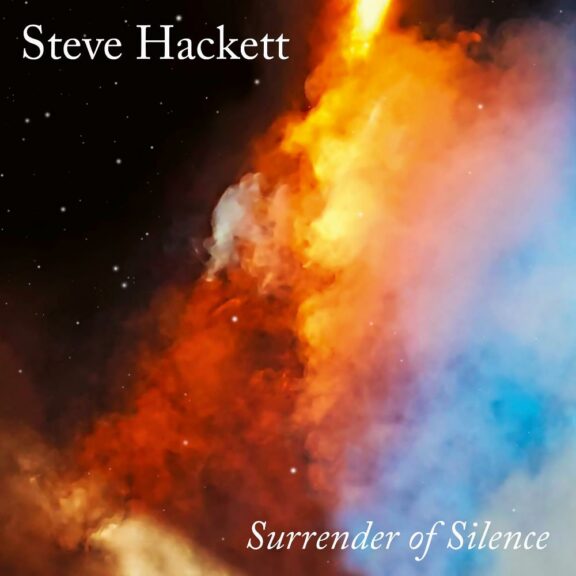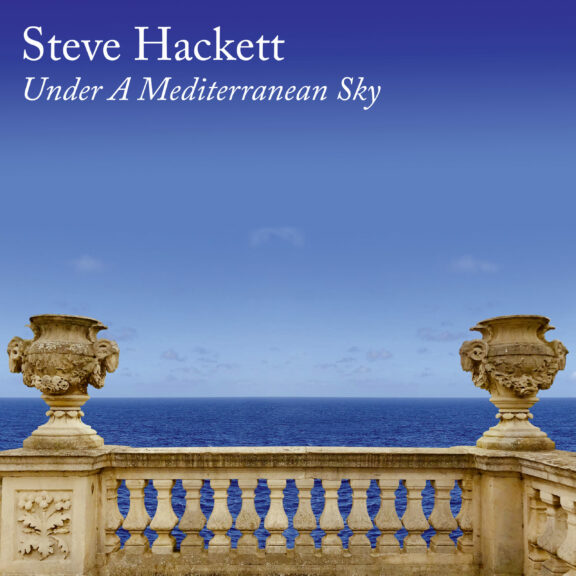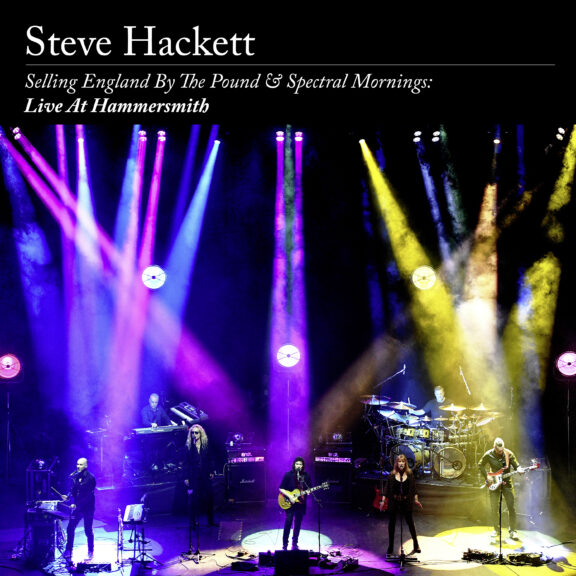Recensione: Wolflight

Chiusa la parentesi del Genesis Revisited con un sostanziale successo, Steve Hackett è tornato a concentrarsi su nuovo materiale inedito e, a distanza di quattro anni dall’ultimo lavoro, pubblica Wolflight, arricchendo una già notevole discografia da solista.
Dopo oltre quarant’anni di carriera sembra difficile poter aggiungere ancora qualcosa, eppure Hackett si è sforzato di mescolare nuovamente le carte in tavola mettendo insieme le sue principali influenze, il progressive, la musica classica, il blues, il folk, e tentando di dare loro una veste nuova. Quello che colpisce subito di questo album è l’atmosfera spesso cupa, notturna, e la disinvoltura con la quale il chitarrista inglese amalgama culture e generi diversi. L’uso di particolarissimi strumenti tradizionali, scoperti attraverso anni di tour, si unisce infatti alla massiccia presenza di sezioni orchestrali influenzate dalla musica dell’Europa dell’est, portando l’ascoltatore a viaggiare continuamente tra l’antica penisola balcanica e la Russia dell’800, passando per l’Inghilterra degli anni ’70. Ad accompagnare Hackett in questa nuova fatica ci sono Roger King (tastiere), Nick Beggs (basso) e Gary O’Toole (batteria), mentre a Malik Mansurov, Sara Kovaks e Rob Townsend sono affidati il tar, il didgeridoo e i il duduk.
A introdurre l’album troviamo la strumentale “Out of the Body”, tipica overture che ha il compito di aprire in grande stile molti dischi progressive, non troppo significativa in questo caso. Con la title track invece si cambia subito registro, il brano comincia in punta di piedi con il tar, strumento a corde di origine mediorientale, cui segue un arpeggio di chitarra classica. Tutto procede attraverso una strofa che ricorda il sound dei Genesis e sfocia nel primo dei numerosi stacchi orchestrali, interrotto dopo pochi secondi da percussioni cupe, le quali a loro volta svaniscono per far spazio a strumenti rock. La struttura è piuttosto articolata e durante i suoi otto minuti il pezzo resta su livelli eccelsi.
La successiva “Love Song To a Vampire” non è da meno: raffinata e misteriosa, si mantiene delicata nella strofa per esplodere nel ritornello e, proprio quando gli archi sembrano annunciarne la conclusione, riparte a pieno ritmo portando con sé un ottimo assolo di Steve. Il brano, oltre a essere uno dei migliori dell’album, vanta anche la presenza di Chris Squire (Yes) al basso. “The Wheel’s Turning” è forse l’episodio più bizzarro: l’atmosfera iniziale ci fa sentire per un momento in un tendone da circo, ma poco dopo già sfuma per fare emergere una strofa dal ritmo abbastanza sostenuto. Il ritornello suona più sereno rispetto a quelli ascolti fino ad ora, così il successivo intermezzo sinfonico, che anche qui arriva inaspettato a fermare tutto per poche battute. Una sezione strumentale per dare spazio agli assoli e quindi un’ultima comparsa del ritornello ci conducono verso il finale ma, mentre il pezzo sfuma, riaffiora per qualche istante un motivo circense simile a quello dell’introduzione. “Corycian Fire” è una delle tracce con vistose influenze etniche e comincia con tutta calma, per poi animarsi nella seconda parte. Si possono ascoltare ancora una volta quei particolari strumenti che hanno tanto affascinato Hackett, mentre la comparsa dei cori nel finale conferisce un tono epico al tutto.
“EarthShine”. Qui protagonista è la sola chitarra classica, che riafferma il caratteristico gusto per gli arpeggi dell’ex-Genesis, ma l’atmosfera, soprattutto nella parte centrale, resta in linea con quella generale dell’album: tanto per intenderci, non si tratta di una nuova “Horizons”. La piacevolissima “Loving Sea” si regge su una ritmica acustica, alla quale si affianca una seconda chitarra nel ritornello, facendo riaffiorare timidamente qualcosa dei Genesis anni ’70. Semplice, breve, ma ben riuscita in definitiva.
“Black Thunder” è guidata da un riff di matrice blues ma dal taglio moderno. Non si può considerare tra i pezzi più importanti, ma anche qua le contaminazioni sono molte e il finale è impreziosito da archi e sax che creano un particolare effetto di film horror d’altri tempi. Con “Dust and Dreams”, terza e ultima strumentale, ci si rilassa seguendo l’andamento quasi ipnotico dei primi tre minuti, durante i quali la Gibson di Steve può trovare tutto lo spazio necessario per esprimersi al meglio. Nella seconda metà le melodie si fanno più drammatiche e si collegano a quelle della ballata “Heart Song”, che, escludendo la prima strofa, si basa su un unico motivo. Un ultimo assolo di chitarra e la musica sfuma, portandoci alla fine del viaggio.
Con Wolflight Steve Hackett dimostra di saper produrre ancora un buon disco elegante e di qualità, di voler tentare qualcosa di diverso, seguendo liberamente la sua ispirazione. Certo, non è un lavoro privo di difetti, alcuni momenti non convincono appieno, altri passaggi possono dare l’idea di essere un po’ demodé, ma la musica non ha sempre bisogno di farci saltare sulla sedia per essere apprezzata, e, soprattutto, se un artista come lui, dopo una lunga carriera, riesce sempre a mantenersi su questi livelli, non si può che esserne contenti.