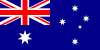Recensione: Wolfmother
I Wolfmother sono un trio di giovani australiani ed in Australia c’è il deserto, c’è il sole, c’è la polvere e ci sono le rocce. In Australia ci sono cieli infiniti, soli abbacinanti e terre riarse. Agli australiani devono essere piaciuti parecchio i primi Black Sabbath e magari anche i Led Zeppelin, perché no. A questi tre signorini, i gruppi sopraccitati piacciono sicuramente e la musica di Tony Iommi deve essere entrata in circolo presto e bene. Generalmente allergico a nuove rivelazioni e sensazioni da stampa garage oriented, mi sono avvicinato a questo album spinto da una motivazione assolutamente demenziale, la cover ed il logo, senza curarmi troppo delle buone recensioni del disco.
Messo il cd nel lettore vengo assalito da suoni assolutamente vintage, da una batteria secca, pulita, incalzante, da riff di chitarra sabbathiani e da uno stile vocale a metà tra Ozzy e “Percy” Plant, non credevo alle mie orecchie! Lungi dal trovarci di fronte a qualcosa di rivoluzionario, l’ascolto di questo album farà la felicità di quanti amano farsi trascinare dall’energia elettrica ed epidermica del rock sabbathiano e settantiano in generale, senza però le cupezze dark di alcuni esponenti del movimento stoner. Non troverete suoni molto acidi ed assoli torrenziali, niente Kyuss qui, solo rock veramente vecchia maniera, di quelli da ascoltare a palla mimando un riffing pesante e grasso.
Lampi di assoluta ispirazione si respirano nella mitica “Mind’s eye” (che titolo ragazzi!) dall’inizio pacato, pronta poi ad esplodere col calore del sole al tramonto dopo poche battute, sorretta da un accompagnamento di hammond su cui si erge un granitico riff. Vera libidine! L’imberbe Stockdale canta con trascinante passione, dimostrandosi davvero forte. Altri highlights dell’album sono l’opener “Dimension”, “White Unicorn” a metà tra gli Zeps di “Houses of the holy” ed i Black Sabbath, la quasi motorheadiana “Woman”, la fantastica “Withcraft” con tanto di assolo di flauto andersoniano, la trascinante “Love Train” e la personale “Where Eagles Have Been” . Questi i titoli sicuramente di maggiore valore, ma tutto il disco gode di grande qualità e non v’è traccia di riempitivi di sorta. Come nei grandi album degli anni che furono i Wolfmother giocano tutte le carte di una giovane e vivace creatività, giocando a fare i retrò. Se è vero che un disco così trent’anni fa avrebbe fatto sfracelli, oggi il terzetto dovrà combattere per non tornare nell’anonimato, ma, vi prego, non fate morire band come questa, il rock ne ha bisogno per ritrovare le sue radici, il suo calore, la sua forza. Le mode vanno e vengono, così come i flussi e riflussi dei sottogeneri più o meno metallici, ma qui, in questi riff pulsa il cuore di un mondo ancora spensierato, baciato dai raggi di un sole nascente.
D’accordo, è vero, i Wolfmother citano parecchio (dai Sabbath agli Zeps, dai Tull ai Beatles) ma diamine, se questo è il risultato, evviva le citazioni! Non parlatemi delle novità, voglio starmene nella polvere di questo sound, insuperato ed insuperabile.