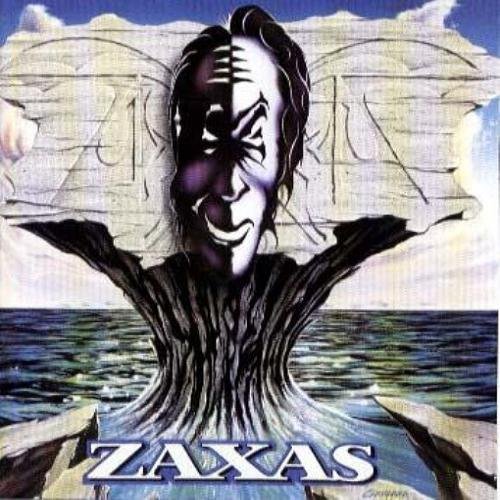Recensione: Zaxas
Negli anni in cui il revival di sonorità più o meno tradizionali ha portato molti gruppi a riformarsi e pubblicare nuovi album, il nome degli Zaxas rimane avvolto nella nebbia. Ben poco si sa della formazione di San Diego, secondo alcune notizie i membri si conobbero in Giappone durante il servizio militare nel corpo dei marines, solo un paio di foto ufficiali circolano in rete, eppure nel 1995, dopo alcuni demo, strapparono un contratto con la Noise Records.
Non si segnalano successive collaborazioni di rilievo dei musicisti coinvolti, assenti pure informazioni su concerti o tour di supporto a questo debut. Se però analizziamo le note all’interno del booklet, oltre all’ascendenza cristiana espressa nei testi, scopriamo che il disco è prodotto da un certo Jim Faraci, non proprio uno sconosciuto. Il songwriting porta la firma di tutta la band, suggerendo un affiatamento non scontato. In questo gioco dei misteri una cosa è certa… la musica. L’album ha in dote una capacità compositiva che colpisce ed emoziona anche dopo un quarto di secolo dalla sua pubblicazione.
Non abbiamo molte coordinate, ma se volessimo provare a descriverne il sound potremmo azzardare un incontro tra l’approccio vocale di Ronnie James Dio e quello strumentale dei primi Queensrÿche, con alcuni influssi che richiamano i Savatage nelle parti soliste, mentre l’utilizzo di un certo “riverbero” nel suono delle chitarre dona personalità alla proposta.
In The Anvil e Images of Princes troviamo potenza e melodia, ritmiche rocciose e dinamiche, linee vocali che alternano aggressività e note alte, riff riconoscibili e stacchi strumentali pregevoli. Mr. Primetime riporta alla mente i Black Sabbath di Dehumanizer, con refrain che colpiscono fin dal primo ascolto pur non cercando mai facili soluzioni. Lies in the Balance è un altro brano dal carattere preciso, ma è con Revolving Door, pezzo simbolo di tutto l’album e dal grande potenziale live, che l’impatto emozionale raggiunge uno dei livelli più alti. In the Beginning conferma l’attenzione posta in fase di composizione, con arpeggi che creano momenti di sospensione e assoli inseriti perfettamente nel contesto. I ritmi serrati di Soul Survivor lasciano spazio a White Room Life in cui la melodia portante non replica mai se stessa ma si muove continuamente a sostenere la voce. Arrivati a Last Chance Believer ci rendiamo conto che col procedere del disco il sound è sempre più riconoscibile, anche in presenza di aperture catchy nei ritornelli. Gli strumenti continuano a dialogare con grande sintonia nella conclusiva Ashes to Ashes, dove le scelte vocali sembrano rendere omaggio a Geoff Tate.
Se dopo tanti anni stupisce trovarsi di fronte a canzoni così ben costruite, stupisce meno che pochi al tempo se ne fossero resi conto. Come detto più volte la prima metà dei Novanta è stato un periodo particolare, la “scena” c’era, ma viveva di dischi “segreti” come questo. Album che il tempo ha reso quasi magnifici, nonostante alcune asprezze e ingenuità, a dimostrazione che non importano mega produzioni per scrivere brani dannatamente efficaci, quando ci sono idee e la perizia strumentale è messa al servizio delle composizioni, diversamente da adesso, dove la tecnologia serve troppo spesso a nascondere l’assenza di anima.
Una band nata dal nulla, difficile da accostare ad altre, dei veri e propri outsider dell’US metal. Dopo un lungo silenzio, nel 2015 sono riapparsi con Returns the Machine, release autoprodotta e disponibile solo in versione digitale, in cui a tratti viene abbandonata la componente heavy a favore di un hard rock dagli influssi seventies e di una piacevole impronta Savatage-oriented, con pezzi di livello più che buono, dove però la magia di questo debutto si è un po’ persa.
Zaxas resta un disco che merita di essere riscoperto, per gli amanti di queste sonorità un unico consiglio… cercatelo e fate in modo che entri nella vostra collezione.